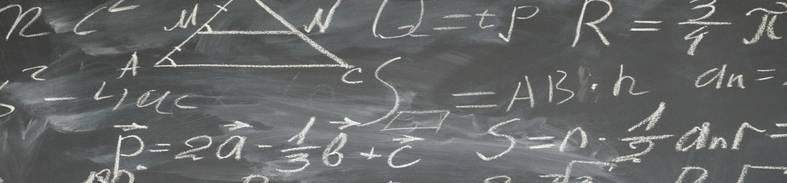
Progetto CLODIA
- Regione Veneto (DGR n.4069 del 30/12/2008) - interventi previsti dalla LR 15/2007
- Titolo del progetto “CLODIA - per lo sviluppo sostenibile degli ambienti costieri”
Il Progetto CLODIA, nato dalla sinergia tra l’Università di Padova (sede di Chioggia del Dipartimento di Biologia) il Comune di Chioggia (Ass. Pesca, Cultura, Formazione) e Legacoop Veneto – Lega pesca (Centro Servizi di Chioggia), ha come obiettivo di contribuire alla salvaguardia e alla gestione responsabile delle risorse marine anche attraverso la diversificazione, valorizzazione e riconversione delle imprese di pesca.
Articolazione delle attività di ricerca:
Nell’ambito della ricerca, finalizzata allo sviluppo e alla riconversione professionale degli operatori della pesca, si collocano due linee dedicate alla molluschicoltura con una particolare attenzione all’ ampliamento di conoscenze mirate sia al futuro ripopolamento che all’allevamento sperimentale di bivalvi autoctoni. In particolare, pur perseguendo obiettivi comuni, gli interventi di ricerca sono articolati in:
- analisi per futuri interventi di ripopolamento della vongola Chamelea gallina (bevarassa);
Negli ultimi anni il sovrasfruttamento, il mancato reclutamento giovanile, ripetuti e consistenti eventi di mortalità hanno contribuito a determinare un depauperamento dei banchi naturali della vongola di mare (bevarassa) Chamelea gallina, che rappresenta una risorsa alieutica tra le più importanti e tipiche del Nord Adriatico. Questa situazione ha portato ad una drammatica riduzione dei proventi derivanti dall’attività di pesca della specie e ad un conseguente calo dello sforzo di pesca, con una limitazione spaziale e/o temporale dell’accesso alla risorsa ed un passaggio degli addetti ad altre attività di pesca o acquacoltura. Una migliore conoscenza della biologia di base della specie C. gallina può aiutare a definire corretti criteri per la gestione della risorsa e a suggerire strategie per il ripristino dei banchi naturali, fino ai preesistenti livelli di sostenibilità. Attraverso questo approccio conoscitivo potranno essere create le basi necessarie per future attività di ripopolamento, quali interventi di trapianto di adulti e giovanili. Attraverso campionamenti periodici la popolazione di C. gallina viene caratterizzata in termini di mortalità, densità, distribuzione delle classi di taglia, tassi di crescita e reclutamento di giovanili. Sui giovanili viene indagata l’ontogenesi gonadica, su individui adulti vengono studiati il ciclo gonadico e quello delle riserve energetiche, indice di condizione, rapporto sessi e fecondità.
- Ampliamento dell’attività di molluschicoltura di specie autoctone: allevamento sperimentale di pectinidi (canestrelli)
Nell’Alto Adriatico il mercato dei bivalvi è sostenuto da attività sia di pesca che di allevamento. La molluschicoltura, che rappresenta un’ importante voce socio-economica dell’acquacoltura italiana, è tuttavia sostenuta dall’allevamento di due sole specie: il mitilo Mytilus galloprovincialis e la vongola filippina Ruditapes philippinarum). La scarsa diversificazione della produzione costituisce un rischio perché eventi non prevedibili, come l’insorgenza di nuove patologie o cambiamenti climatici, possono compromettere la resa economica dell’intero comparto. Iniziative tese a verificare la possibilità di allevare altre specie di molluschi di pregio commerciale possono pertanto aprire nuove prospettive di sviluppo della molluschicoltura, in particolar modo se le specie prese in considerazione sono attualmente sfruttate esclusivamente attraverso la pesca, come nel caso dei canestrelli. I canestrelli o pettini fanno riferimento a più generi tra cui prevalgono Chlamys (“canestrelli rossi”) ed Aequipecten (“canestrelli bianchi”), che si differenziano, oltre che dal punto di vista tassonomico, anche per caratteristiche organolettiche e modalità di commercializzazione. Nell’Alto Adriatico i canestrelli vengono pescati mediante pesca a strascico con ramponi e rapidi, i cui effetti impattanti sui fondali variano in funzione del tipo di fondale e della specie bersaglio. Pertanto l’allevamento di queste specie potrebbe contribuire ad una riduzione non solo del prelievo sui banchi naturali, ma anche ad una mitigazione degli effetti ambientali causati da questo tipo di pesca. Il primo problema da affrontare per l’avvio di un’attività di molluschicoltura è il reperimento del “seme”, cioè dei giovanili neoinsediati, che possono essere recuperati attraverso l’uso di specifici collettori. Si rende pertanto necessaria una sperimentazione mirata inizialmente a verificare la possibilità di raccogliere seme delle diverse specie di canestrello, quantificandone la presenza nelle diverse stagioni. Con il seme raccolto possono essere successivamente allestite prove di allevamento in contenitori adeguati alla crescita di questi bivalvi, sfruttando per l’allevamento impianti di mitilicoltura offshore. Su canestrelli pescati e allevati vengono indagati mortalità, accrescimento, ontogenesi gonadica, ciclo gametogenetico, ciclo delle riserve energetiche, indice di condizione, fecondità.
Coordinatore
- Prof. Maria Berica Rasotto ( Unità di ricerca: Ecoetologia e Biologia Evoluzionistica )
e-mail: mariaberica.rasotto@unipd.it
Team di ricerca
- dr.ssa Maria Gabriella Marin ( Unità di ricerca: Ecologia marina )
email: maria.marin@unipd.it - dr.ssa Monica Bressan, monica.bressan@unipd.it





